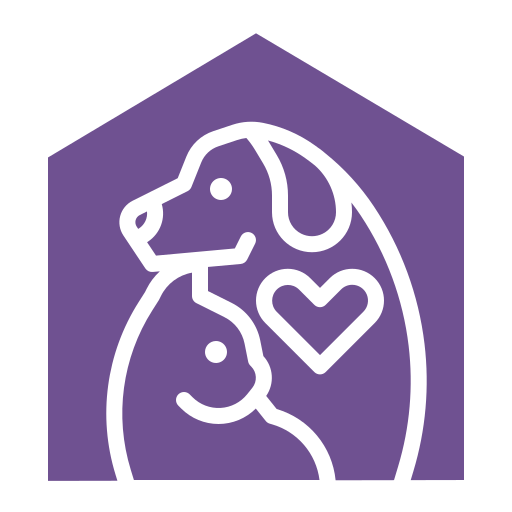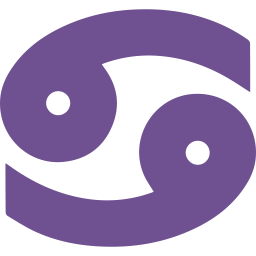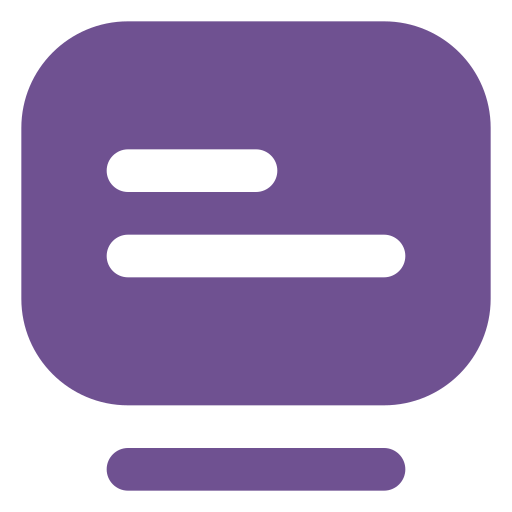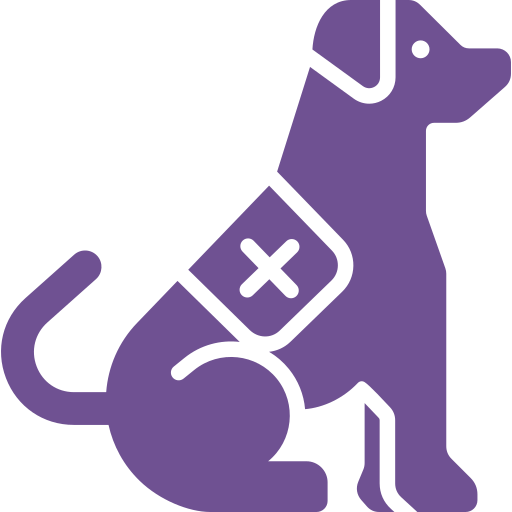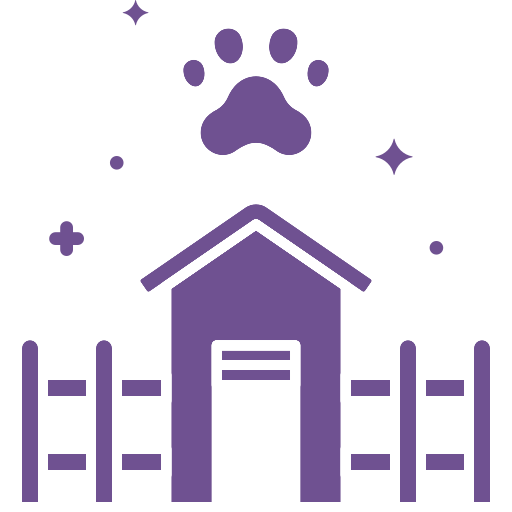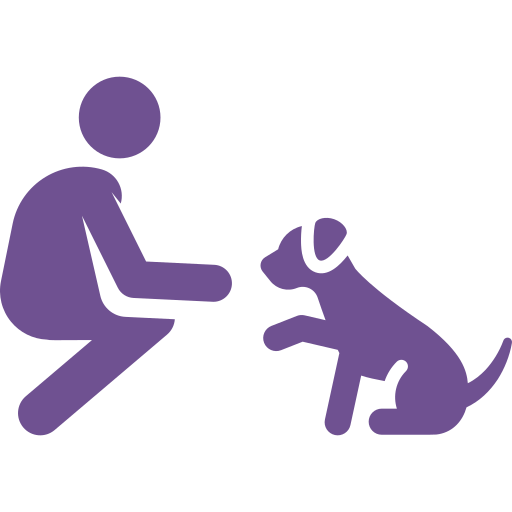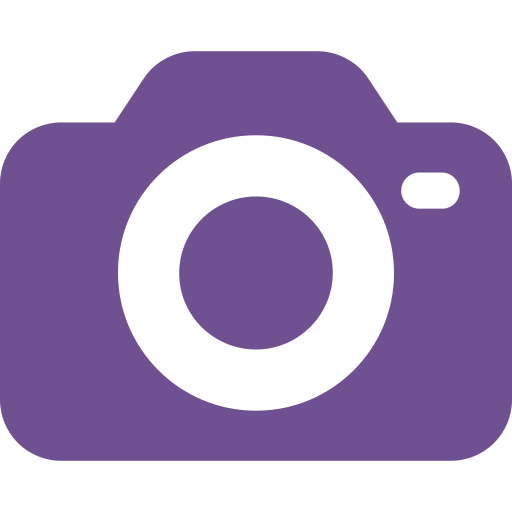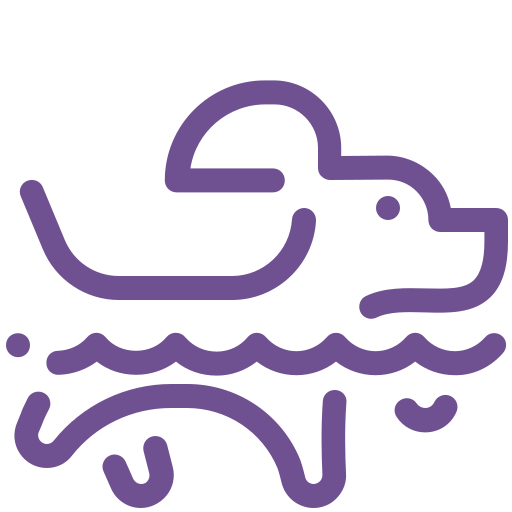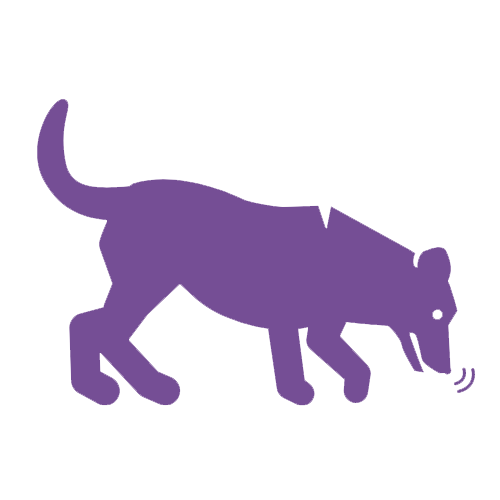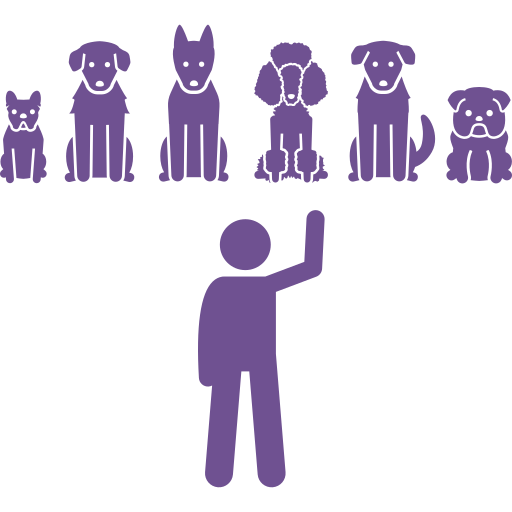Che cosa è?
La Leishmaniosi canina è definita una malattia da vettori, in quanto il parassita responsabile dell’infezione, il protozoa Leishmania infantum, è trasmesso da piccoli insetti ematofagi (pungono per nutrirsi di sangue come le zanzare), chiamati flebotomi o pappattaci.
Questi insetti sono silenziosi e sono attivi soprattutto alla sera e durante la notte fino all’alba nella stagione calda che dipende dalla zona geografica considerata.
Volando riescono a percorrere fino a 200 metri, ma possono raggiungere distanze maggiori se trasportati dal vento.
La temperatura ideale per la loro vitalità va dai 15° ai 25° e amano l’umidità.
Quando il flebotomo punge un animale ammalato, il parassita si localizza nel suo apparato buccale, pronto per essere inoculato negli animali successivamente punti.
E’ una malattia nuova?
Non lo è.
La Leishmaniosi canina è nota da almeno centinaia di anni sotto il nome di Malattia di Aleppo.
Il primo studioso a descriverla è stato il medico e naturalista scozzese Alexander Russel nel 1756.
Ma la storia del genere Leishmania si perde nella notte dei tempi: ci sono varie teorie che ci portano addirittura nel Mesozoico (252-66 milioni di anni fa).
Ci sono descrizioni di lesioni cutanee compatibili con la Leishmaniosi che compaiono su tavolette assire.
Sono state trovate tracce di DNA mitocondriale in mummie egizie del 2050-1650 a.C.
Il nome Leishmaniosi lo si deve al patologo scozzese William Boog Leishman, che nel 1900 scoprì un parassita sconosciuto su un paziente deceduto a Calcutta.
Poco più tardi il medico fisiologo irlandese Charles Donovan riuscì a studiare meglio il nuovo parassita a livello citologico.
Dalle loro scoperte nacque la Leishmania donovani e seguirono infiniti studi.
Dove è più diffusa?
La malattia è diffusa dove vive prevalentemente il suo vettore, il flebotomo, che ama
i climi caldi, come quelli di molte aree dell’Africa Orientale, dell’Asia Sudorientale e dell’Europa.
In Europa il vettore è diffuso soprattutto nei territori che si affacciano sul bacino mediterraneo, inclusa l’Italia. Altre aree sono la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Francia meridionale.
In Italia, le regioni considerate tradizionalmente endemiche sono la Liguria, le aree costiere del Centro-Sud, soprattutto il versante Tirrenico e le isole.
Recenti indagini epidemiologiche hanno registrato nuovi focolai anche in territori del Nord Italia, tra cui alcune zone del Piemonte, del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Che sintomi può dare la Leishmaniosi canina?
Potremmo definire questa malattia poliedrica, a causa dei molteplici sintomi clinici che la caratterizzano.
Il periodo di incubazione varia da 1-3 mesi ad alcuni anni e non tutti gli animali infetti poi manifestano la malattia.
I sintomi principali della Leishmaniosi canina sono: spossatezza, dimagrimento cronico, aumento di volume dei linfonodi, alterazioni squamose della pelle con ulcerazioni (che generalmente partono dalla zona della testa), perdita del pelo, ipercheratosi (soprattutto localizzata al tartufo e ai cuscinetti delle zampe), crescita eccessiva delle unghie, epistassi, febbre, debolezza, ingrossamento della milza e del fegato, insufficienza renale, disturbi del sistema nervoso centrale, alterazioni oculari (cheratiti e congiuntiviti, blefarite).
Il decorso spesso è cronico.
Quali analisi fare?
Gli esami sono molteplici.
In caso di sospetto clinico si procede con emocromo, biochimico, elettroforesi, esame chimico-fisico delle urine con PU/CU, test ELISA semiquantitativo, PCR effettuata da campioni bioptici di linfonodi, milza o midollo osseo.
Cosa influisce nella progressione della malattia?
Sicuramente la carica parassitaria.
Si è visto che più alta è la carica parassitaria, tanto più veloce è la progressione e tanto più gravi sono i sintomi clinici.
Influiscono anche la genetica, le eventuali patologie concomitanti (infettive, neoplastiche, parassitarie, autoimmuni) e i farmaci immunosoppressori.
Quali sono le terapie indicate?
Esistono dei protocolli terapeutici, che il medico curante vaglierà e sceglierà in base al quadro clinico.
Fondamentale è avere una stadiazione precisa della malattia, che spesso si fatica ad incasellare in rigidi schemi terapeutici a causa dell’infinita variabilità del quadro del paziente.
L’inserimento nei protocolli assodati della medicina integrata è una risorsa preziosa ai fini di sostenere il sistema immunitario del cane in terapia.
Come si può prevenire la Leishmaniosi canina?
Esistono dei protocolli terapeutici, che il medico curante vaglierà e sceglierà in base al quadro clinico.
Fondamentale è avere una stadiazione precisa della malattia, che spesso si fatica ad incasellare in rigidi schemi terapeutici a causa dell’infinita variabilità del quadro del paziente.
L’inserimento nei protocolli assodati della medicina integrata è una risorsa preziosa ai fini di sostenere il sistema immunitario del cane in terapia.
Come si può prevenire?
L’approccio alla prevenzione di questa malattia è multiplo e va studiato con il veterinario curante in base al rischio epidemiologico.
In primis, è fondamentale dare al cane una barriera anti feeding, ovvero bisogna impedire che il nostro cane venga punto.
Questo lo si fa applicando al cane i vari collari/spot on in commercio registrati per la prevenzione della Leishmaniosi, facendo attenzione nella scelta alle eventuali specie conviventi (le permetrine possono essere mortali per i gatti).
Utilissimo a questo scopo è l’Olio di Neem, dotato di potente repellenza e presente in commercio sotto forma di collare, spray, shampoo, medaglietta, salviettine…
Per aumentare la competenza del sistema immunitario in commercio esiste una soluzione orale a base di domperidone, da usarsi secondo un protocollo preciso: una volta al giorno per bocca, secondo il peso del paziente, tutti i giorni nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
Infine esiste il vaccino, che va somministrato ai sieronegativi, con richiamo annuale (in Italia in commercio al momento ce ne è uno solo).
Nessuna di queste strategie assicura una protezione del 100%, nemmeno il vaccino.
Per questo, nella prevenzione della Leishmaniosi canina è fondamentale riferirsi al proprio curante, che conosce sia la situazione epidemiologica che lo stile di vita del paziente, ed è in grado di costruire un efficace piano di battaglia contro la malattia.
Anche i cani ammalati vanno protetti con gli antiparassitari, affinché non trasmettano la malattia attraverso la puntura del flebotomo.
Esistono razze sensibili e razze resistenti alla malattia?
Sì, tra le razze più sensibili sembrano esserci il Boxer, il Pastore Tedesco e il Rottweiler.
Tra quelle più resistenti troviamo il Podenco e il Cirneco dell’Etna, che da secoli vivono in aree fortemente endemiche e che probabilmente hanno sviluppato il modo di convivere con la malattia.
La Leishmaniosi canina può colpire l’uomo e gli altri animali?
Sebbene in Italia il cane rappresenti tra gli animali il serbatoio principale per Leishmania infantum, è possibile che anche il gatto e i roditori selvatici ne vengano colpiti.
E’ possibile che colpisca anche l’uomo, soprattutto anziani, bambini e soggetti immunodepressi, sempre tramite puntura dei flebotomi, ma finora non è stata mai rilevata una infezione diretta da contatto con cani infetti.
E infine la domanda da un milione di dollari: ma dalla Leishmaniosi si può guarire?
La risposta è davvero complicata.
Ci sono cani che muoiono, altri che hanno recidive e altri che si negativizzano sia al sierologico che all’esame del midollo.
La totale remissione dall’infezione è riportata in moltissimi casi.
Ma questa può essere definita guarigione clinica ma non definitiva.
La cosa certa è che il paziente in remissione è un “guardato a vista”, nei confronti del quale non va mai abbassata la guardia e il cui sistema immunitario va sostenuto con ogni mezzo possibile.